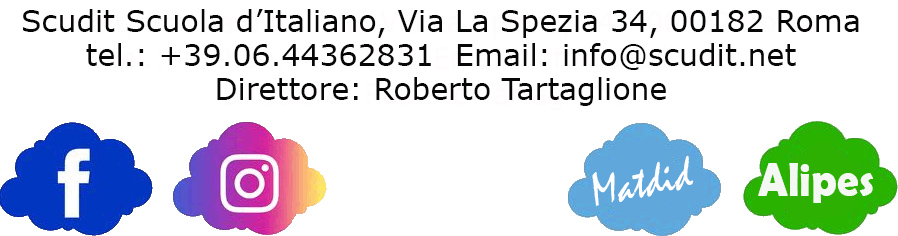Il ruolo della donna, nella Roma antica, era ben
definito: moglie e madre. E il suo universo era quello, chiuso e
privato, della casa. "Lanifica, pia, pudica, frugi, casta,
domiseda" cioè impegnata nel tessere la lana, devota, pudica,
frugale, casta e che sta a casa: queste le doti di una donna in
un'iscrizione romana. Se ne possono aggiungere due - silenziosa e
prolifica - ed ecco la perfetta matrona, sogno di ogni uomo
dell'antichità (?). La moglie era completamente sottomessa al marito: i
testi degli scrittori latini non lasciano dubbi in proposito, e
nemmeno il diritto romano.

Scena di
matrimonio (dextrarum iunctio - unione delle destre)
su
un altare funerario, I secolo d.C.
(Roma, Museo Nazionale Romano)
Dovere principale della donna era procreare, per il bene dello Stato.
Molti mariti, nel loro testamento, lasciavano una dote alla moglie solo a
una condizione: una volta rimasta vedova doveva risposarsi e fare altri
figli con il nuovo marito. "Preservare le doti delle donne è
nell'interesse pubblico. È davvero necessario che le donne continuino
ad avere una dote per procreare e dare figli alla città",
scrive il giurista Pomponio (Digesto).Una donna prolifica era un bene pubblico, cosicché poteva succedere che
"se un marito romano aveva un numero sufficiente di figli da
allevare, un altro, che non aveva figli, poteva convincerlo a lasciargli
sua moglie, consegnandogliela a tutti gli effetti, o solo per una
stagione" (Plutarco).
E poteva succedere che il marito "cedeva" sua moglie anche se
era incinta, come era successo a Marzia, ceduta dal marito, il celebre
Catone Uticense, a Quinto Ortensio Ortalo, che scrive: "Secondo
la legge di natura è una cosa giusta e onorevole per lo Stato che una
donna nel fiore della sua giovinezza e bellezza non debba né spegnere
il suo potere riproduttivo rimanendo inattiva né generare più figli
del necessario, gravando e impoverendo un marito che non ne vuole".
A ognuno dei suoi eventuali mariti la donna doveva essere devota e
fedele. Gli scrittori latini citano come esempio di devozione assoluta
la matrona Porzia,
figlia di Catone Uticense. Moglie di Marco Giunio
Bruto, uno degli assassini di
Giulio Cesare, alla notizia della morte del marito (42 a.C.)
Porzia si uccide, ingoiando dei carboni ardenti: "Quando
venisti a sapere che il tuo sposo Bruto era stato sconfitto e
ucciso a Philippi,
poiché non ti si dava un pugnale, non esitasti a inghiottire castissimi
carboni ardenti, imitando
con
il tuo coraggio femminile la morte virile di tuo padre" (Valerio
Massimo).
I carboni ingoiati da Porzia sono "castissimi",
perché la castità era stata la dote principale di questa donna
coraggiosa. E la castità era una delle virtù fondamentali: la
legge riconosceva al marito il diritto
di punire il tradimento della moglie con la morte.

TIZIANO,
Tarquinio e Lucrezia, 1571
Esempio assoluto in questo campo è Lucrezia. Suo marito
Tarquinio Collatino e alcuni giovani nobili, mentre mangiavano e
bevevano abbondantemente, avevano fatto una scommessa: chi aveva
la moglie più virtuosa? Collatino aveva condotto gli altri a casa
sua, di notte, e tutti avevano potuto vedere che la sua sposa era in
casa e stava tessendo la lana (domiseda e lanifica).
Nel gruppo di mariti ubriachi c'era anche Sesto Tarquinio (figlio
di Tarquinio il Superbo, ultimo re di Roma), che subito aveva
perso la testa per Lucrezia. Di nascosto Sesto era andato da lei,
per supplicarla di diventare la sua amante, ma Lucrezia lo aveva respinto. Allora l'aveva ricattata: se
non cedi, ti ucciderò, poi metterò accanto al tuo corpo quello
di uno schiavo, nudo, e tutti penseranno che sei stata uccisa
"in vergognoso adulterio".
A questo punto Lucrezia aveva ceduto, per paura non della morte ma
del disonore. Quando Sesto se ne era andato via, aveva chiamato il
padre e il marito, gli aveva raccontato tutto e si era uccisa
"perché in futuro, seguendo il mio esempio, nessuna donna
viva disonorata (impudica)" (Tito Livio).
Infine, altra dote indispensabile era il silenzio, che "reca
grazia alla donna" (Sofocle). La parola, che esprime e comunica
il pensiero, era considerata prerogativa degli uomini e le donne avevano
il dovere di tacere, perché erano incapaci di fare buon uso del
linguaggio, proprio in quanto donne. In questo senso, è chiarificatrice
la storia di Tacita Muta, dea del silenzio.
In origine Tacita era una ninfa e si chiamava Lala (dal verbo
greco laleo, "parlare"). Parlava, ma troppo, e a
sproposito. Era stato Giove a renderla muta: Lala, infatti, aveva
raccontato a sua sorella Giuturna che il dio la amava, rendendo inutili
così le strategie che lui pensava di attuare per conquistarla. Giove,
arrabbiato, le aveva strappato la lingua. Non bastasse, la povera
Lala-Tacita Muta era stata violentata dal dio Mercurio, che doveva
accompagnarla nel regno dei morti; e aveva partorito due gemelli, i Lari
compitales, che proteggevano i confini e quindi la città.
Non c'è che dire: casalinghe disperate a dir poco...
|