Quando ho cominciato a muovermi in questo
strano lavoro (insegnare l’italiano agli stranieri nei primissimi anni
Ottanta era ancora abbastanza “pionieristico”) ho chiesto a un giovane
Luca Serianni se sapeva indicarmi qualche libro o un autore che si
occupasse della materia. E lui, che già da giovane sapeva tutto, mi ha
fatto il nome di “un certo Katerinov” che era uno dei pochi o forse
l’unico che della faccenda se ne intendeva parecchio.
Leggo i suoi primi libri (in particolare “il Katerinov grigio”, meno
noto del più noto “Katerinov rosso” che è stato il manuale per migliaia
se non milioni di studenti per un ventennio) e come tutti i giovani
decido subito che lui era vecchio (perbacco, all’epoca questo Katerinov
avrà avuto addirittura quarant’anni e quindi doveva essere superato no?)
e che io facevo e avrei fatto naturalmente di meglio.
Insegno per qualche tempo all’estero e in Italia sempre convinto del
fatto che io avevo capito tutto e il “vecchio Katerinov” era roba da
archeologia.

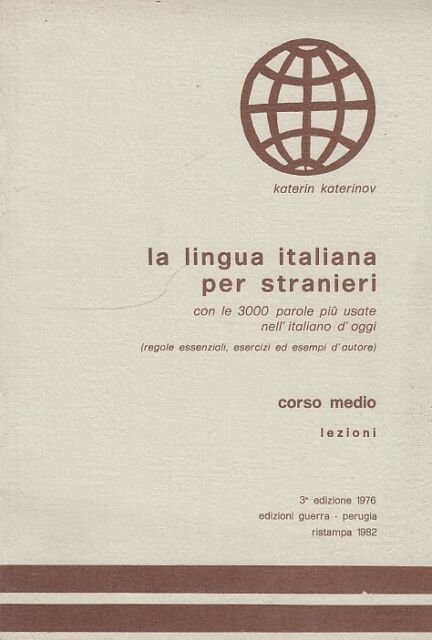
Ho poi occasione di conoscerlo, fugacemente ma personalmente, qualche
tempo dopo. Anche se non ho parlato troppo con lui di didattica e di
italiano, ricordo che conoscendolo ero rimasto parecchio impressionato:
ero giovane e stupido ma un po’ di naso ce l’avevo e, parlandoci, avevo
capito subito che quell’uomo in classe doveva essere un portento. Cioè:
non era come quegli altri che nel frattempo cominciavano a affrontare
“l’italiano per stranieri” in modo accademico (cioè snocciolando teorie
sull’acquisizione della lingua magari senza aver mai visto uno
straniero). No, lui si vedeva che “sapeva” farlo quel lavoro, che in
classe ti insegnava davvero l’italiano e che i suoi studenti si
innamoravano di lui già dalla prima lezione.
Passa ancora un po’ di tempo e ci ritroviamo ogni tanto in qualche parte
del mondo: ci siamo incontrati certamente a Madrid, a New York e a
Istanbul e in quelle occasioni abbiamo avuto anche modo non dico di fare
amicizia, ma almeno di fare un po’ di chiacchiere amichevoli. E scopro
così che la mia vita si era incrociata con la sua anche in altre
occasioni.
Da studente viveva in una borgata romana, Torre Maura, dove abitavo
anch’io. E frequentava il cinema di terza visione “Delle Rondini” di cui
mio padre era il direttore. E non solo. All’università di Roma aveva
fatto parte del gruppo di filologia romanza, sotto la guida di quel
geniaccio del professor Aurelio Roncaglia che poi sarebbe stato anche
mio professore e relatore della tesi.

Forse per questi piccolissimi punti in comune, ho avuto l’impressione
che si fosse sgelato nei miei confronti anche dal punto di vista
“professionale”: per quel che ricordo non era sempre tenerissimo con chi
gli si affiancava (sia pure col massimo dell’umiltà), e tuttavia,
davanti a un bicchiere di vino, una volta, una volta sola eh?, ha fatto
perfino un bell’apprezzamento su una mia conferenza sul “linguaggio
della pubblicità”, magari solo per simpatia verso il pivello. Cosa che io avrei messo volentieri nel curriculum se
solo qualcuno ne avesse capito l’importanza.
Comincio allora a pensare che tutta quella carta stampata dopo i suoi
famosi libri “archeologici” e spesso spacciata come portatrice di nuove
verità didattiche caratterizzate da nomi altisonanti e vuoti, non era
poi così originale o migliore dei vari libri “del Katerinov”:
crocianamente direi anzi che in didattica non possiamo non dirci
katerinoviani, tutti indistintamente. E il motivo è semplice: ha
inventato tutto lui, prima degli altri. Si fa presto a prendere in giro
(come facevo io) il suo “manuale rosso” che a pagina 30 ti diceva con
precisione “adesso sai 185 parole”. “Buu!” ululavano i comunicativisti
di primo pelo cresciuti a base di didattica dell’inglese e a suon di
autenticità omogeneizzate, di livelli sogliola e di deduttività di
grammatiche mal digerite. In realtà lui già si muoveva con destrezza in
una logica di linguistica computazionale ancora quasi da inventare, tra
lessico di frequenza e contrastività.
E del resto anche la sua passione per l’informatica fa parte del
personaggio speciale che era: nel 94 mi parlava di una bomba che sarebbe
esplosa sul mercato l’anno dopo: Windows 95! E faceva di tutto per far
capire agli insegnanti quanto questo avrebbe potuto cambiare, e
migliorare, la didattica. Ma poi, per carattere più che per generazione,
si dimenticava di attaccare un filo elettrico o si perdeva un file,
rendendo le sue bellissime conferenze anche divertenti per il caos
geniale con cui riusciva a condirle.
Questo Mostro Sacro dell’insegnamento dell’italiano a stranieri colpiva
poi per la sua incredibile disponibilità, più tipica di un disoccupato
in cerca di occasioni che di una personalità di quel livello.
Così quando a Roma ero stato incaricato dalla Pubblica Istruzione di
fare uno dei primi corsi di didattica per insegnanti di scuola pubblica
che in quegli anni si ritrovavano in classe i primi immigrati (hanno
chiesto di farlo a me non per meriti acquisiti, ma solo perché
probabilmente ero l’unico disponibile sul mercato) ho domandato
timidamente a Katerin se voleva e poteva fare un intervento in una
lezione. E lui sapeva benissimo che glielo domandavo un po’ perché
naturalmente quello che poteva dire lui era interessantissimo e un po’
perché, portando il Katerinov in persona, anche io avrei fatto un
figurone. E lui ha accettato in un secondo, senza esitare. Se ne fanno
più di tipi così?
Il giorno del suo intervento è venuto con la altrettanto celeberrima
moglie, Maria Clotilde Boriosi, coautrice di tutti i suoi libri e anche
lei didatta di fama internazionale. Dovevano dividersi l’intervento, ma
quando Katerin comincia a parlare tutti notiamo che ha qualcosa: è teso,
sembra spaventato, non si sente bene, con una mano si massaggia il
cuore. Tutti preoccupati lo fermiamo e qualcuno lo carica in macchina
per portarlo di corsa in ospedale a fare un controllo.
La moglie che fa? Dice “Be’, lo spettacolo deve continuare”, prende in
mano le redini della situazione e comincia a parlare lei. In sala è
immenso lo stupore per la sua freddezza.
Ma dopo la conferenza, quando le chiedo “Ma Katerin? Pensi sia una cosa
seria?” lei risponde tranquilla: “Roberto, se dovessi angosciarmi ogni
volta che lui racconta di star male o pensa di avere un attacco cardiaco
non vivrei più! Sta’ tranquillo, Katerin sta benissimo”.
E questo è il modo con cui ho scoperto che era uno sfrenato
ipocondriaco.
Altre sono state le occasioni in cui ci siamo incontrati. È venuto anche
a Scudit, la mia scuola, a fare un seminario per gli insegnanti,
partecipando poi a una serata in una frasca a Frascati dove, fra due
canzoni fatte con la chitarra, un bicchiere di bianco e una fettina di
porchetta (e tante sigarette!) sembrava di stare con un ex compagno di
scuola con cui farsi due risate alle spalle del mondo.

Perché ho sentito il bisogno di scrivere queste righe su Katerin
Katerinov? Perché quando se n’è andato, nel 2016, io neanche l’ho
saputo, tanto poco rilievo è stato dato alla notizia. In un paese dove i
talenti giovani espatriano e quelli vecchi sono vittime di invidie,
acidumi e oscuramenti, così è toccato a Katerin il destino di essere
sempre al limite tra il mondo accademico e l’outsider. Poche le
celebrazioni, poco il risalto dato al personaggio, generale silenzio sui
mezzi di informazione: sembra quasi che la sua assenza metta in
imbarazzo quanto la sua presenza.
Io non sono stato suo allievo, non ho imparato da lui “un metodo”, non
sono stato purtroppo un suo amico, non ho copiato (se non involontariamente!) i suoi
materiali, non porto le bretelle e non posso certo sentirmi uno dei suoi
eredi. Ma, simpatia personale a parte, non posso non dirmi
katerinoviano.

|